Pubblichiamo l'intervento del prof. Zamagni, rivisto dall'autore, al convegno del 21 marzo scorso in sala Dalle Fabbriche a Faenza
Il volume che ora viene presentato al giudizio del lettore è un bell’esempio di lavoro intellettuale nel senso attribuito a questa espressione dal card. John Newman. Con non comune maestria, Toso è riuscito a tenere insieme, in armonia, una varietà di prospettive di studio, da quella teologico-morale e quella politico-filosofica, a quella socioeconomica. Scritto in maniera esemplarmente chiara, Chiesa e Democrazia (Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa, Seconda edizione rivista ed ampliata, 2025 Roma) sarà certamente apprezzato da quanti amano essere stimolati a pensare in modo libero senza paraocchi. Il filo rosso che tiene uniti i vari capitoli è la crisi profonda, iniziata mezzo secolo fa, della democrazia quale modello di ordine sociale nei paesi dell’Occidente avanzato e l’apporto decisivo che la Chiesa-popolo di Dio è in grado di offrire per il suo superamento.
La questione etica
In quanto segue, intendo fissare l’attenzione su tre questioni specifiche che questo saggio pone alla nostra responsabile attenzione. Con ammirevole coraggio intellettuale, Toso affronta il dilemma in cui si dibatte la Chiesa di oggi: se vuole restare fedele al suo fondamento deve affermare con forza che il cristianesimo non è riducibile ad un’etica; al tempo stesso però per affermare nel mondo la sua cogente rilevanza, la Chiesa deve saper declinare il suo messaggio sul fronte dell’etica, mostrando quali implicazioni di ordine pratico discendono dall’accoglimento dei principi, sempre gli stessi, del Cristianesimo. Invero, come è stato ribadito più volte, anche alla Settimana Sociale di Trieste del luglio scorso, l’Evangelo è bensì un messaggio di speranza, ma non esclude, anzi esige che ve ne siano altri. Nello svolgere la sua missione, la Chiesa cerca e incontra la risposta di un soggetto tra le onde della storia. Come viva quest’uomo, quali siano le sue possibilità di realizzarsi non sono fatti estranei e indifferenti alla evangelizzazione, poiché da essi dipende la risposta che l’uomo darà. Ecco perché la Chiesa – insiste Toso – non può non interessarsi alla sorte dell’uomo in questo mondo e alla sua piena fioritura. È contro la ricorrente tentazione di un nichilismo generatore della sindrome, oggi dilagante, della solitudine esistenziale che l’Autore di questo libro si scaglia con decisione, riaffermando le ragioni proprie della Dottrina Sociale della Chiesa, che inizia dalla ben nota Lettera a Diogneto (II sec.) e dalla pubblicazione dell’importante saggio di Basilio di Cesarea (Sul buon uso della ricchezza, 370).
L’impegno in politica dei cattolici
Una seconda questione, strettamente collegata alla precedente, è quella che concerne l’impegno in politica dei cattolici, un tema al quale tante pagine del libro sono dedicate. (Si badi di non confondere la politica, che secondo Aristotele appartiene alla “ragion pratica”, con la partitica che nasce nel XIX secolo, al seguito dell’Illuminismo, e che appartiene alla ragion tecnica). Distinguendo tra comunità cristiana e comunità civile, in quanto appartenente ad entrambe, il credente non può eludere il problema di come armonizzare le due appartenenze, dal momento che i principi fondativi delle due comunità sono diversi e così pure le loro regole di funzionamento. Per il non credente, un tale problema non esiste. Il fatto – riconosciuto e ribadito più volte da papa Francesco – della fine della cristianità dell’epoca moderna, ci obbliga ad affrontare la questione della armonizzazione nel pieno rispetto del principio di laicità che, come noto, è creazione del Cristianesimo. (L’Illuminismo ha dato vita, d’altro canto, al principio laicista). A scanso di equivoci, conviene sempre ricordare la differenza tra Cristianesimo e cristianità: quest’ultima è l’involucro storico, e dunque transeunte, del primo.
Il teologo Henry De Lubac ha scritto che il cristiano che non si interessa di politica – non di partitica – non è fedele al Vangelo. A tale proposizione mi piace affiancare tre dichiarazioni recenti di altrettanti Pontefici. “La politica come servizio è una via della Carità: volete amare gli altri? Fate politica” (Paolo VI). “Sogno il ritorno diretto in politica dei laici cattolici”. (Benedetto XVI, corsivo aggiunto). “Un buon cattolico si immischia in politica, offrendo il meglio di sé”. (Francesco). Non v’è bisogno di commenti, se non per suggerire due conseguenze derivanti dalla non presa in considerazione di tali autorevoli ammonimenti. Per un verso, il babelismo (per usare la felice espressione di J. Maritain) del mondo cattolico; per l’altro verso, il fatto che i cattolici sono spesso percepiti come una sorta di lobby a difesa di determinati obiettivi, e non invece come una comunità di persone portatrici di un progetto di trasformazione della società che trae il suo slancio vitale dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Le lobby – di “destra”, di “sinistra” o di altro ancora – se possono ottenere vantaggi nella anticamera della partitica, sono sempre perdenti a lungo termine per la semplice ragione che non sono in grado di organizzare, o non vogliono organizzare, i canali di trasformazione degli interessi della cittadinanza verso le forze partitiche in quanto esse non perseguono l’interesse generale. Un caso di studio interessante ci viene dal nostro mondo cattolico che si è autoinflitto, nell’ultimo quarantennio, una duplice illusione: quella di poter essere il lievito che entra nella pasta delle diverse formazioni partitiche per condizionarne, almeno in parte, i programmi, pur non superando la soglia critica oltre la quale si può, essere efficaci; quella di poter esercitare con successo il potere come influenza, a prescindere dal potere come potenza. Davvero pie illusioni, come i fatti si sono poi incaricati di dimostrare.
Chiudo il punto con un esempio chiarificatore. Il Cristianesimo non può considerare la democrazia liberale come l’unico ordine politico definitivo da incoraggiare, perché tale ordine contiene il rifiuto della politica delle virtù. In altro modo, le strutture della democrazia liberale sono basate sull’idea che le virtù e il dono come gratuità possono essere considerati politicamente e socialmente ridondanti. Avallare un’economia del dono significa affermare l’esigenza che la fraternità sia il test della legittimità politica e la carità il criterio della cittadinanza. Non è sostenibile la società in cui si estingue la fraternità e non c’è pubblica felicità in quella società in cui esiste solamente il “dare per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché né la visione liberal-individualista del mondo, né la visione statocentrica della società sono guide sicure per farci uscire dalle secche dell’epoca presente. È d’interesse far presente che J. Habermas, nel suo saggio del 2024, ha insistito sul fatto che le democrazie contemporanee hanno eroso il loro fondamento etico, suggerendo come cosa inevitabile il ritorno al pensiero religioso. “Il Cristianesimo, e nient’altro – ha scritto il filosofo tedesco – è l’ultimo baluardo della libertà, della coscienza dei diritti umani e della democrazia. Continuiamo ad abbeverarci a questa fonte”.
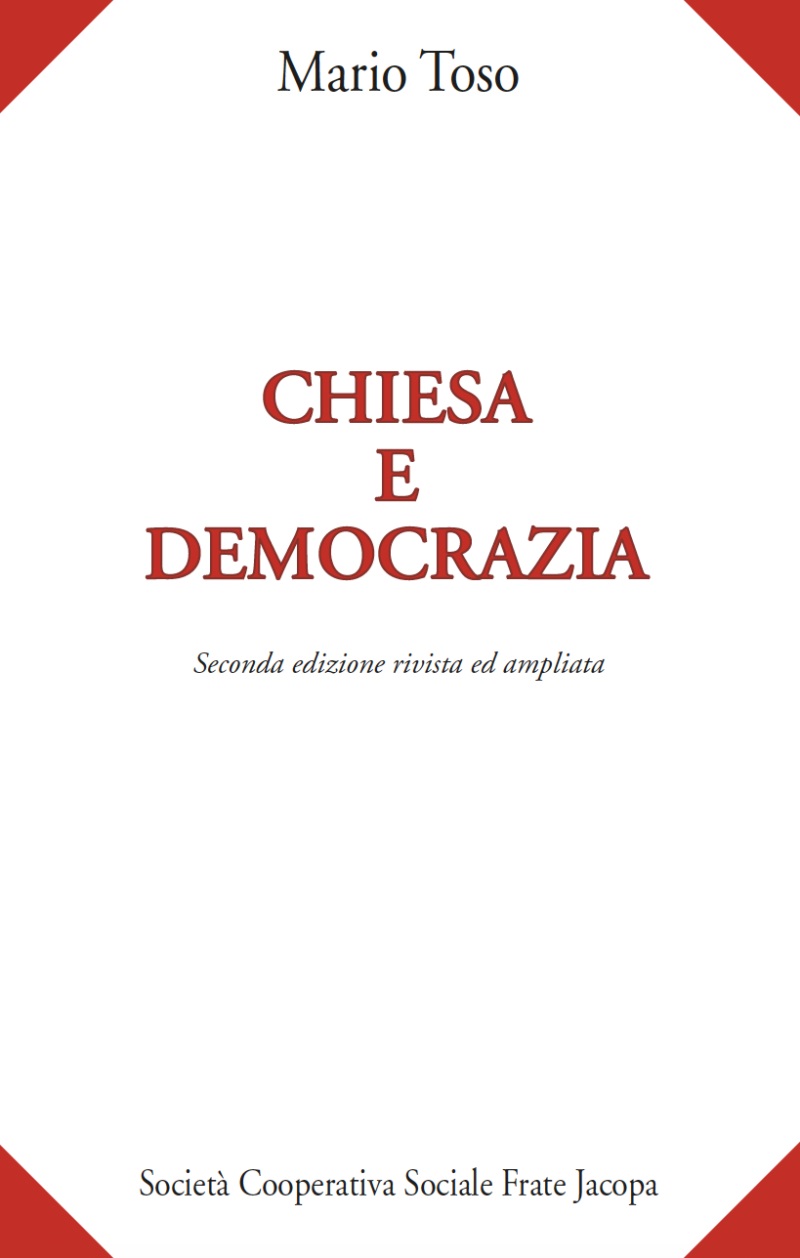
La crisi della democrazia
Passo, infine, alla questione che occupa un posto centrale nell’analisi del Nostro: la crisi della democrazia quale si è venuta manifestando nel corso dell’ultimo mezzo secolo. Tre le patologie all’origine del triste fenomeno: la ipertrofia della finanza globale; la concentrazione di ricchezza mai registrata nei secoli passati; il disallineamento tra mercato capitalistico e principio democratico. A proposito del primo fattore causale, Toso non manca di sottolineare il processo di crescente finanziarizzazione dell’economia, un processo che si è imposto all’attenzione dei più, facendo credere – senza alcuna prova – che i mercati finanziari sarebbero assetti istituzionali in grado di autoregolarsi e ciò nel duplice senso di assetti capaci di darsi da sé le regole del proprio funzionamento e di farle rispettare. Il punto che merita una sottolineatura è che nelle economie di mercato di tipo capitalistico vi sono soggetti che creano valore e altri che non lo creano, ma se ne appropriano oppure si limitano a trasferirlo da un soggetto all’altro. Soprattutto la grande finanza (grandi banche, hedge funds, fondi di private equity, ecc.) mentre crea poco valore nuovo, ha la potente capacità di appropriarsi del surplus che altri agenti hanno generato: è questo il nucleo duro del rent-seeking finanziario, della ricerca della rendita che caratterizza l’attività di buona parte degli intermediari finanziari. Questo stato d’animo pressoché generalizzato ha fornito il carburante al meccanismo speculativo, il quale si è potuto avvalere di strumenti e tecniche con una “potenza di fuoco” mai vista in precedenza. Ma è evidente che una bolla speculativa dalle proporzioni di quella scoppiata nel 2007-2008 mai si sarebbe potuta verificare senza quella “bolla mentale” che ha fatto credere che fosse possibile separare la creazione di valore dal lavoro produttivo. Donde il vergognoso aumento delle diseguaglianze sociali sia tra paesi sia tra gruppi di cittadini entro un medesimo paese. Eppure, il pensiero liberale classico, (si pensi a A. Smith, A. Tocqueville, J.S. Mill, F. Hayek) sin dai suoi albori, aveva avvertito la preoccupazione che una smodata concentrazione di potere economico avrebbe finito col sottomettere al proprio volere il potere politico e dunque la democrazia.
Ciò ci introduce immediatamente al disallineamento di cui sopra. È il capitalismo oligarchico, non più quello democratico, a permettere il progresso socio-economico e la liberazione della società, perché quella democratica è una pratica politica troppo dispendiosa e troppo “wokista”. Si leggano documenti recenti quali il “Manifesto del Capitalismo Oligarchico” scritto da P. Theil nel 2009, in California, e firmato da una potente pattuglia di super ricchi quali Vance, Bezos, Musk e altri; il Programma Scientifico del Claremont Institute, uno dei più efficaci “think tank” dell’ultra-conservatorismo americano; il farneticante “Manifesto Tecno-Ottimista” di M. Andreessen, co-fondatore di Netscape, dell’ottobre 2023, per rendersi conto di quanto sta accadendo in questo tempo. Il linguaggio della liberazione è divenuto preda da parte di poteri che si ammantano per l’appunto di quel linguaggio. Corruptio optimi pessima: siamo di fronte a un sistema che riproduce le parole, i propositi dei liberatori, ma in verità schiaccia le realtà percepite come fragili e vulnerabili in nome di un privilegio di “scorciatoia” in ossequio all’ideologia prestazionale.
Restituire un’anima alla politica
Restituire un’anima alla politica: è questo l’invito accorato che si trae dalla lettura di Chiesa e democrazia. Ci vogliono grandi cause, ancorché talvolta deviate dal loro alveo originale, per mobilitare le persone in gran numero. Non esiste forza politica, degna di questo nome, che non si rifaccia ad un’ispirazione. Perché mai l’ispirazione cristiana non dovrebbe avere cittadinanza nell’odierno spazio politico, al pari delle altre matrici culturali? Nella sfera della politica, la sfida per il cristiano è accorciare le distanze tra radicalità evangelica e azione pubblica.
È culturalmente attrezzato e spiritualmente preparato il nostro mondo cattolico per una tale missione? Ritengo proprio di sì, purché lo si voglia e si abbia l’onestà intellettuale di ammetterlo. Non posso terminare senza esprimere, ancora una volta, gratitudine profonda a mons. Toso per il dono di queste pagine, il cui senso ultimo è quello di contrastare la credenza, oggi di moda, secondo cui non ci si sarebbe bisogno di pensare, perché ciò che conta è fare, funzionare. Ma se l’esistenza è solo funzionamento, tanto vale affidarsi alla “macchina”, che lo farà certamente meglio. Di qui il suggerimento del Nostro rivolto al mondo cattolico a riprendere la via del pensiero pensante, considerato che di pensiero calcolante ce ne è già troppo. Ha scritto Antoine de Saint Exupery: “La perfezione non si ottiene quando non c’è più nulla da aggiungere; ma quando non c’è più nulla da togliere”.
In Chiesa e Democrazia non c’è nulla da togliere.
Stefano Zamagni






